Raramente scrivo articoli breve, se non sono per il web o per i quotidiani. Ogni tanto sono perplessa ma mi piace dare spazio all'approfondimento. Condivido qui un articolo destinato a un settimanale (Verona Fedele) e quindi alla carta stampata. Per cui chiedo venia se il post è più lungo, comunque, c'è pure qualche immagine per bilanciare ;-) Condivido anche la mail di un caro amico, di cui ho 'recensito' l'interessantissimo libro nel servizio postato di seguito. La presentazione è giusto oggi.
Grazie Giorgio, tu sei un grande autore! Mi hai reso il sabato un po' più speciale.
"In questo Verona Fedele hai scritto veramente un bell'articolo: ampio, articolato, approfondito; e suscita interesse per il tema trattato. Grazie, Giorgio"
Argomento: le antiche peschiere di Peschiera
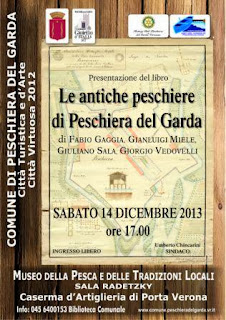.jpg) Quattro autori e un solo fine: far conoscere al pubblico cosa hanno
rappresentato per la vita, l’economia, la cultura di una città gardesana “le peschiere di Peschiera”, cittadina
che nel suo toponimo come pure nel vessillo comunale ne conserva un’evidente
eredità. È l’attività più antica del lago, praticata anche lungo le sponde del fiume
Mincio: la pesca è un’attività storica, in passato vitale, probabilmente
esercitata dall’uomo “fin dalla sua prima presenza”.
Quattro autori e un solo fine: far conoscere al pubblico cosa hanno
rappresentato per la vita, l’economia, la cultura di una città gardesana “le peschiere di Peschiera”, cittadina
che nel suo toponimo come pure nel vessillo comunale ne conserva un’evidente
eredità. È l’attività più antica del lago, praticata anche lungo le sponde del fiume
Mincio: la pesca è un’attività storica, in passato vitale, probabilmente
esercitata dall’uomo “fin dalla sua prima presenza”.
Oggi è anche uno sport ma per secoli ha sfamato famiglie intere e forgiato le tradizioni locali.
A cura del Centro
studi per il territorio benacense, l’ultima pubblicazione di Fabio Gaggia, Gianluigi Miele, Giuliano
Sala e Giorgio Vedovelli ripercorre la storia e l’economia della pesca
gardesana, grazie a indagini certosine e allo studio di documenti ritrovati negli
Archivi di Stato, notarili e nello “Scrigno delle pergamene” del Comune
arilicense. I quattro autori hanno pubblicato il libro “Le antiche peschiere di
Peschiera del Garda” con il supporto del locale Rotary Club e del Garda
veronese, volume che sarà presentato
ufficialmente a Peschiera del Garda sabato 14 dicembre alle 17 (oggi!), presso
il Museo della pesca degli Amici del Gondolin, in Sala Radetzky nella Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona.
È la
prima pubblicazione ad approfondire l’economia di Peschiera nei secolo
passati. D’altronde lo stesso stemma comunale esibisce due anguille, a riprova
di quanto la pesca abbia nutrito e influenzato la comunità arilicense nei
secoli scorsi. Un tipo di pesca, però, che non si limitava alle reti gettate
dalle barche ma che richiedeva ingegno e lavoro, con la costruzione delle
cosiddette peschiere, ovvero strutture fisse, tra l’altro “molto costose, composte
da pali infissi sul fondo del lago e del fiume Mincio con casotti e
dispiegamento di reti di grandi dimensioni che catturavano le trote e le
anguille nel loro percorso migratorio”.

DALLE
PESCHIERE ALLO STABILIMENTO ITTIOGENICO – L’ultima peschiera in
funzione era proprio nel Canale di mezzo, nel cuore di Peschiera. Grazie a una
nota di Floreste
Malfer, che fu ittiologo ed esperto della pesca gardesana, sono state
raccolte presso lo studio del notaio di Mantova Attanasio Siliprandi molte
informazioni aggiuntive su ognuna delle peschiere, il loro valore economico, la
gestione e i passaggi di proprietà. Ogni struttura, si legge nel libro, “era
catalogata con le sue superfici, con le distanze fra i pali e con i differenti
tipi di legno che venivano impiegati per la loro costruzione”.

Nei secoli scorsi il possesso di una peschiera era sinonimo di benessere e potere.
Alla metà dell’Ottocento, ricordano ancora gli autori, esistevano più di venti
peschiere e il Comune arilicense, proprietario della metà, le affittava
solitamente nel periodo autunnale tra la metà di settembre e il 15 dicembre,
quando cioè “si verificava la grande migrazione delle anguille, in settembre e
ottobre, e delle trote, in novembre e dicembre”.
Lo stesso Napoleone, apprendiamo leggendo il nuovo
libro, aveva assegnato Peschiera alla Provincia di Mantova realizzando quella
suddivisione amministrativa auspicabile ancora oggi per la creazione di una “Regione del Garda” che darebbe unità al
più grande lago d’Italia. Il Centro studi per il territorio veronese da
trent’anni fa ricerche sull’ambiente gardesano, senza tenere conto dei confini
amministrativi di province e regioni che spezzano l’area benacense. E il
presente lavoro editoriale, insieme ad altre pubblicazioni a carattere
storico-naturalistico, dà ulteriore supporto all’attività culturale del Museo della pesca e delle tradizioni locali
di Peschiera, allestito presso la Caserma di Artiglieria di Porta Verona
dall’associazione arilicense Amici del
Gondolin.
Gli autori non solo approfondiscono la storia e
il funzionamento delle varie peschiere in età moderna, ma trattano ampiamente
di quella risorsa alimentare ed economica – oggi perduta – che trote e anguille
hanno rappresentato per le comunità rivierasche. Un capitolo è dedicato allo stabilimento ittiogenico di Peschiera
(lungo il corso del Mincio, a ridosso del ponte ferroviario) abbattuto dalle
bombe durante la Seconda guerra mondiale e mai più risorto. Purtroppo la
successiva alterazione del corso del Mincio non permise alle trote di tornare a
fregare nei limi del fiume e così la missione dello stabilimento finì con
l’ultima guerra.
LE
PÉSCHE DI PESCHIERA – Lo studioso Giorgio Vedovelli, nella sua parte dedicata alle antiche pésche di
Peschiera ricorda pure i pescatori
abusivi, uomini “poveri e superbi”
che con fierezza si munivano di “arcagna”
(rete a strascico vietata nei pressi della fortezza arilicense), fiocine e
altri strumenti proibiti dalle leggi.
Vedovelli descrive le resti usate un tempo, a
seconda delle zone e delle stagioni, e le tecniche degli esperti del mestiere.
C’erano reti come la “petrogna”, citata
in documenti del ‘600 e adoperata sui bassi fondali di Sirmione e Lugana
“grazie all’opera di due uomini su una barca” per pescare branchi di ciprinidi
e talvolta anche trote, o la “sibenera”,
una rete a catino che chiamava in azione fino a dodici persone divisi su sei
barche. Quest’ultima era usata sui bassi fondali di Peschiera e Sirmione a
maggio/giugno per catturare barbi, scardove e carpe nel loro periodo della
riproduzione.
Ancora, scrive Vedovelli, la pesca con la fiocina era tipica delle
zone di canneti, a sud del Garda, e famosi per la loro abilità erano i “fiocinatori di Bardolino”: per usarla,
servivano quattro uomini su una barca che uscivano con il lago calmo, nelle
notti senza luna, al chiarore del fascio di canne accese. Si servivano di “una
lunga asta di legno, alle cui estremità era infisso un pettine di ferro con
rebbi in numero variabile da 16 (per tinche e carpe) a 32 (per anguille)”.
Una tecnica di pesca per le anguille era pure
(e in parte ancora lo è) la “sguèrna”
o “lenza morta”: formata dal cordino
di canapa (oggi nylon) buttato sul fondo del lago e lungo anche 15 km, a cui si
attaccava un’esca.
Nei canneti, a dicembre e gennaio, si praticava persino la pesca delle anatre, soprattutto tra
Garda e Bardolino e a Peschiera; si utilizzavano in tal caso vecchie reti
mantellate, come i “tincari”, per aspettare che l’animale vi incappasse nel
cercare cibo sott’acqua.
.JPG) Tutt’oggi, nella discesa verso il mare, le
anguille incappano nelle “roste”, “reti alte circa un metro e lunghe dai 30 ai
50 metri”; finiscono imbrogliate in trappole di rete tenute tese da un telaio
di ferro; un tempo le reti erano composte da robusti graticci di vimini.
Tutt’oggi, nella discesa verso il mare, le
anguille incappano nelle “roste”, “reti alte circa un metro e lunghe dai 30 ai
50 metri”; finiscono imbrogliate in trappole di rete tenute tese da un telaio
di ferro; un tempo le reti erano composte da robusti graticci di vimini.
In
inverno, le occasioni di pesca calavano e a febbraio/marzo, lungo le rive del
basso Garda, anche le donne uscivano con reti di lino o con piccole fiocine per
la pesca degli scazzoni, buoni per ottime fritture o come esce per le
tirlindane.
Nelle immagini sopra: due tavole, della pesca della forca e il Caolo della notte, e una veduta del Mincio a Peschiera del Garda.









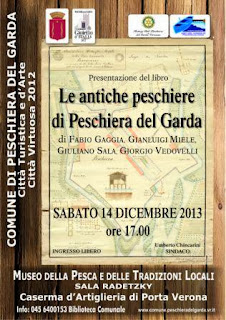.jpg)



.JPG)















